(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)
È una coincidenza raramente commentata, ma quando Apple ha lanciato il suo iPhone nel giugno 2007 la crisi finanziaria era in realtà già in atto. Chiamata una costruzione rischiosa del debito subprime mercato immobiliare degli Stati Uniti, e nel 2007 i prezzi delle case hanno cominciato a scendere drasticamente. Il mercato azionario ha reagito, dapprima titubante, poi con un massiccio ritiro degli investimenti. Nel settembre 2008, la casa d'investimenti americana Lehman Brothers è fallita, provocando forti scosse nel mondo finanziario e nell'economia mondiale. Il periodo della storia recente, in cui eravamo tutti connessi da macchine intelligenti con interfacce più piccole, era così anche un periodo di tracollo economico, gestione della crisi politica, tagli, insurrezioni, tumulti e lotta di classe – nel mezzo di tentativi altrimenti tenaci di ripristinare lo status quo. La storia è familiare, il contrasto sorprendente. Mentre diversi stati nazionali erano sull’orlo della bancarotta e del vero e proprio collasso sociale, Apple ha guadagnato circa 2500 miliardi di corone danesi nel primo decennio dopo la crisi.
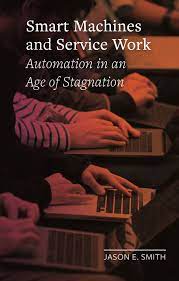 La storia che ci viene presentata più spesso riguarda la crisi e il successo della ripresa. Una storia di come il capitalismo attraverso la «distruzione creativa» e tecnologica rottura creato le condizioni per un nuovo ciclo di crescita economica guidato dall’innovazione tecnologica e dall’imprenditorialità individuale. La storia della Silicon Valley, della Big Tech e di Steve Jobs, in altre parole.
La storia che ci viene presentata più spesso riguarda la crisi e il successo della ripresa. Una storia di come il capitalismo attraverso la «distruzione creativa» e tecnologica rottura creato le condizioni per un nuovo ciclo di crescita economica guidato dall’innovazione tecnologica e dall’imprenditorialità individuale. La storia della Silicon Valley, della Big Tech e di Steve Jobs, in altre parole.
La pandemia e la crisi in corso sono una parentesi in questa storia. Corona-il vaccino e l’elezione di Joe Biden indicano che presto il capitalismo dovrà essere riacceso. Proprio come la macchina a vapore annunciò la prima rivoluzione industriale, var lo smartphone un primo avvertimento della terza rivoluzione industriale, una nuova era di «macchine intelligenti» connesse in un’unica grande rete: case intelligenti, auto intelligenti, città intelligenti e un pianeta intelligente. Allacciare il casco e allacciati.
La tendenza del tasso di profitto a diminuire
Mentre aspetti che la pandemia venga contenuta, puoi trarre beneficio dalla lettura di due ottimi libri che di fatto fanno scoppiare la bolla di illusioni in cui vivono ancora molti investitori e futuristi. Se vuoi capire cosa riserva il futuro, allora probabilmente starai meglio lettura Macchine intelligenti e lavoro di servizio: l'automazione nell'era della stagnazione di Jason E. Smith, e Automazione e futuro del lavoro di Aaron Benanav – piuttosto che leggere le previsioni economiche tradizionali o l’ultima letteratura accelerazionista.
Come sottolineano sia Smith che Benanav, lo siamo, nonostante l’esplosione del mercato smart gadget, automobili a guida autonoma, robot avanzati, algoritmi di autoapprendimento e automazione – continuano a dover affrontare il fatto fondamentale che la produttività è in costante calo da decenni. Gli aumenti di produttività, dovuti sia alla microgestione che all’automazione, rappresentano altrimenti una condizione inevitabile per la crescita economica. Ma la produttività e la crescita sono in calo e lo sviluppo sembra proseguire asintoticamente verso lo zero.
Sebbene i progressi nella potenza di elaborazione, nella capacità di archiviazione e nell'hardware siano stati enormi
All’inizio dell’era dei computer, l’aumento della produttività era ben al di sotto delle aspettative.
Come sottolinea Jason E. Smith nel suo libro, non è più compito esclusivo dei teorici marxisti della crisi evidenziare la tendenza del tasso di profitto alla caduta. Che i profitti siano diminuiti per diversi decenni a partire dai primi anni '1970 è un semplice fatto statistico, un fenomeno che, tra gli altri, l'economista Larry Summers, consigliere economico durante l'amministrazione Clinton, ha chiamato “stagnazione secolare”. Allora come è possibile che, a distanza di dieci anni dall'inizio della rivoluzione “intelligente”, non vediamo ancora i risultati riflessi negli aumenti di produttività e nella creazione di crescita?
Già nel 1987 l’economista americano vincitore del Premio Nobel descrisse Roberto Solow un paradosso simile: «L’effetto dei nuovi supercomputer e della tecnologia dell’informazione», scrive Solow, «sembra apparire ovunque tranne che nelle statistiche sulla produttività». Sebbene i progressi nella potenza di elaborazione, nella capacità di archiviazione e nell’hardware siano stati enormi agli albori dell’era informatica, passò solo un breve decennio da quando Intel inviò il primo microchip commerciale sul mercato nel 1971 fino a quando IBM fu in grado di introdurre il personal computer, o PC, in 1981 (e Jobs seguì l’esempio nel 1984 con la macchina di culto Macintosh) – allora Solow poté constatare che l’aumento di produttività che avrebbe dovuto far avanzare i risultati finanziari era molto lontano dalle aspettative. Perché?
Stagnazione economica
Smith mostra i Macchine intelligenti come gli economisti nel tempo abbiano costruito un mare di ipotesi più o meno plausibili per (via) spiegare gli inesistenti aumenti di produttività. Poche di queste ipotesi sono convincenti, alcune sono puramente un pio desiderio e molte di esse sono addirittura contraddittorie. Smith esamina le principali argomentazioni del mainstream economico e analizza i set di dati che sono alla base delle previsioni future di una produttività imminenteIncremento a parte.
Egli sottolinea che gran parte della confusione che circonda la mancanza di crescita è semplicemente dovuta al fatto che si dà per scontato che i precedenti modelli di sviluppo economico si ripeteranno necessariamente. Molti economisti non tengono conto delle condizioni storicamente specifiche che offrono opportunità di crescita economica. La prima rivoluzione industriale creò valore e profitti attraverso lo sfruttamento della manodopera a basso costo proveniente dalla terra, così come dalle ex colonie e piantagioni di schiavi. Nuovi processi industriali di estrazione, lavorazione e distribuzione dovevano rifornire un mercato mondiale in rapida crescita, e la domanda sia di manodopera che di beni cresceva di pari passo con l’impulso dei motori a vapore che succhiano fossili, i “cotonifici satanici” che mantenevano il girano le ruote della macchina capitalista. Allo stesso modo, la “seconda” rivoluzione industriale, come viene tipicamente chiamato il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, è stata caratterizzata da condizioni ottimali per la crescita e la creazione di valore. Una combinazione di mercati del lavoro ampliati, progressi tecnologici e mercati maturi per una serie di nuovi prodotti industriali di massa – automobili, frigoriferi, lavatrici, televisori e aspirapolvere – furono tra gli ingredienti della crisi economica del dopoguerra. boom negli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta: l’epoca d’oro del capitalismo.
Le condizioni per la crescita economica – come durante le precedenti rivoluzioni industriali – lo sono
non più presente oggi.
Ma il punto fondamentale di Smith è che le condizioni per la crescita economica durante le precedenti rivoluzioni industriali non sono più presenti oggi. È questa differenza storica che sia gli ottimisti che i pessimisti trascurano quando discutono di come si svilupperà l’automazione durante la “terza” rivoluzione industriale in corso nell’era delle macchine intelligenti: “Chiamatela automazione 2.0. Ma mentre la prima ondata di automazione ha avuto luogo durante il boom del dopoguerra, le discussioni attuali si concentrano su quella futura rottura del mercato del lavoro si verificano durante una stagnazione economica grave e prolungata.
Deindustrializzazione
Per Smith, il punto chiave è che storicamente la crescita è stata guidata dall’industria. Ma il settore è in ritirata. Ovunque, da Detroit a Nakskov, vediamo chiari segni di deindustrializzazione. E come indica il titolo del libro di Smith, il fiorente settore dei servizi, che secondo una stima ha ora assorbito oltre il 50% della forza lavoro globale, non può far ripartire la crescita in un’economia di mercato capitalista in difficoltà.
Il lavoro nel settore dei servizi – sia in settori come l’assistenza agli anziani e all’infanzia o nelle libere professioni come parrucchieri, tatuatori, autisti o vari servizi di consegna – è semplicemente difficile da conciliare con l’imperativo capitalista di un costante aumento della produttività. In parte, gran parte di questi compiti rientra nella natura della questione tecnico visto molto difficile da automatizzare, e in parte c'è ben poco economico incentivo a investire in possibili tecnologie di risparmio di manodopera in un settore in cui il lavoro è in gran parte svolto da piccoli lavoratori autonomi o da manodopera a basso costo e non organizzata.
L’emergente “settore dei servizi” non riesce a rilanciare la crescita in un’economia di mercato capitalista in difficoltà.
La conclusione per Smith è chiara: non esistono soluzioni intelligenti a un problema strutturale che ha a che fare con le dinamiche contraddittorie del capitalismo. La ridondanza del lavoro salariato, la creazione di quello che Marx chiamava un «esercito di riserva» globale e la crescente precarizzazione sono collegate ad altre cause, più profonde, che non possono essere ridotte a una questione di nuove scoperte tecnologiche e di automazione della produzione. Molti dei cosiddetti Big Tech le aziende utilizzano in larga misura le tecnologie esistenti, anche se per nuovi scopi, e per aziende come Uber, Lyft o Airbnb, la più grande innovazione «tecnologica» è sufficiente per minare di fatto il contratto di lavoro, scrive Smith.
«Automazione completa»
Nel libro Automazione e futuro del lavoro Aron Benanav prende atto anche delle numerose profezie sull'automazione della produzione dopo la crisi del 2008. La storia dell'arrivo dei robot non è nuova. Ora i robot potrebbero non chiamarsi più Frankenstein o R2D2, ma Siri, Alexa, AlphaGo o Yaskawa Motoman MH24. Possono imitare le voci, parlare le lingue del mondo, prenotare biglietti aerei, battere i maestri di scacchi e annientare qualsiasi opposizione umana nel millenario gioco di strategia cinese go. Sì, MH24 può persino usare la spada come un vero samurai giapponese.
La domanda allora è se, a lungo termine, i robot potranno anche fare il bagno agli anziani, strigliare un barboncino, tatuarsi la pelle dello stomaco o piegare il bucato. Non è improbabile. Ma è comunque ikke è particolarmente probabile che qualcuno investa la quantità di capitale necessaria per rendere superflui tali servizi, che spesso sono estremamente mal pagati o semplicemente forniti gratuitamente. I robot stanno arrivando, senza dubbio. Ma probabilmente solo dove il prezzo del biglietto d'ingresso può essere guadagnato una volta tornati a casa, con interessi e interessi composti.
Sia che si canti le lodi dell’automazione o la si tema, scrive Benanav, l’utopia della “piena automazione” si basa su una comprensione semplicistica delle dinamiche economiche. È semplicemente sbagliato ritenere che il dilagante sviluppo tecnologico sia responsabile dell’aumento della disoccupazione globale, della “sottoccupazione cronica” e della deindustrializzazione. Così come, al contrario, è sbagliato presumere che l’automazione libererà il lavoro e ci aiuterà ad abolire il capitalismo. Ci troviamo di fronte a un corso molto più complesso della storia economica. Benanav descrive un circolo vizioso di concorrenza globale, calo dei prezzi, eccesso di capacità, inerzia tecnologica (piuttosto che innovazione) e diminuzione degli incentivi a investire come causa della prolungata crisi del capitalismo.
Benanav e Smith chiaramente non sono d'accordo su ogni dettaglio dell'analisi. Tuttavia, entrambi gli autori concordano sul fatto che il capitalismo sta esaurendo le forze. Noi possiamo strisciare pazzesco quanto vogliamo, ma nostro smartphone difficilmente sarà l’elemento che rilancerà l’economia mondiale e risolverà la crisi una volta che la pandemia sarà finita.


